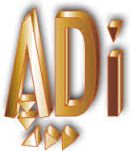La professione docente
nel dossier “La buona scuola”.
ADi , 3.10.2014
Che insegnante esce dalla Buona scuola? Come viene trattato questo enorme, variegato esercito di “dipendenti pubblici” che da tempo ha smarrito il senso della propria identità e la visione della propria funzione? L’ADI ne propone una prima sintetica valutazione.
Dal 1974 non si mette mano allo Stato giuridico, cioè a quell’insieme di norme e di principi che definiscono il sapere professionale, il ruolo e le condizioni in cui la funzione docente viene svolta. Eppure in questi 40 anni ci sono state rivoluzioni che hanno sconvolto modi, luoghi e tempi dell’apprendere, hanno messo in crisi l’organizzazione del sapere e la tradizionale divisione delle discipline e hanno sepolto gli antichi miti che descrivevano il “bravo” insegnante.
In questa situazione, è stata elaborata e offerta alla discussione “La buona scuola” del Governo Renzi.
I punti positivi
L’ADI ha assunto la
proposta in modo costruttivo, non foss’altro perché non ci si può
permettere di perdere quest’ultima occasione, e ne ha rilevato
alcuni aspetti positivi.
Un nuovo Stato giuridico
Si intaccano per la
prima volta i pilastri della conservazione sindacale, burocratica e
partitica, ai quali la scuola è inchiodata dagli
anni 70. Si afferma la volontà del Governo e del Parlamento di
riappropriarsi della condizione dei docenti, varando un nuovo
Stato giuridico e decretando la fine, o quantomeno il
ridimensionamento, dell’esperienza fallimentare della
contrattualizzazione del rapporto di lavoro avviata nel 1995.
Stabilità del corpo docente
Si esprime la volontà
di superare il precariato e di risolvere
il cinquantennale tormentone del binomio
graduatoria ad esaurimento e graduatoria da concorso per titoli ed
esami.
Avvio di
sviluppo professionale e valutazione dei docenti.
Si fa un cenno, per quanto limitato, all’articolazione della carriera (il docente mentore) e a nuove modalità di valutazione dei docenti.
Ma non è tutto oro quello che riluce.
Le contraddizioni inconciliabili con una nuova docenza
“Non si può avere la
botte piena e la moglie ubriaca”.
Non si possono assumere
150.000 insegnanti nel 2015, andando oltre la sentenza della Corte
europea, e altri 40.000 nel triennio 2016-2019, e pensare nel
contempo di valorizzare la professione docente. Ci penserà forse il
MEF a ridimensionarne l’entità ma non ci si può esimere dallo
stigmatizzare che si è nuovamente di fronte all’utilizzo della
scuola come ammortizzatore sociale per la disoccupazione
intellettuale. Questa impostazione demolisce qualsiasi prospettiva
di qualificazione della professione e di miglioramento della scuola.
Con questa infornata di assunzioni, che sono il triplo rispetto ai
posti vacanti (50.000), non si avrà mai nessuna rivalutazione
retributiva e l’insegnamento rimarrà un mestiere di ripiego.
Organico funzionale: un vicolo cieco già sperimentato.
A parte il numero eccessivo di insegnanti che andrebbero a costituire l’organico funzionale, il tipo di utilizzo appare nella maggioranza dei casi insostenibile. Una quota di insegnanti sarebbe utilizzata per le supplenze anche brevi, un ruolo di tappabuchi a vita, dequalificante e demoralizzante. Soluzioni per affrontare il problema delle supplenze brevi vanno ricercate in una diversa struttura oraria degli insegnanti, in un’organizzazione scolastica che superi il modello militaresco delle classi e in un uso intelligente delle tecnologie digitali. Va inoltre proposto un maggior livello di autonomia e di responsabilizzazione degli studenti accompagnato a un forte ridimensionamento normativo, almeno nella secondaria di 2° grado, delle responsabilità civili a carico degli insegnanti e della scuola nei confronti della tutela dei minori, come peraltro avviene in altri sistemi europei.
Oltre alle supplenze, l’altro utilizzo dell’organico funzionale è rivolto all’ampliamento dell’offerta formativa. La scuola italiana non ha bisogno di ampliamenti, abbiamo già un curricolo esorbitante e un numero di ore di insegnamento fin troppo elevato. C’è necessità di fare meglio con meno. E’ questo il caso del liceo quadriennale e dell’introduzione generalizzata negli Istituti professionali delle qualifiche triennali e dei diplomi quadriennali. Altro che ampliare.
Né va dimenticato che
l’organico funzionale è già stato sperimentato negli anni Ottanta e
fu un fallimento.
Il merito si valuta in ingresso.
Qualsiasi politica che
intenda valorizzare il merito deve intervenire prima delle
assunzioni. Questo hanno fatto tutti i Paesi che hanno risultati
alti nelle indagini internazionali, basti citare la Finlandia e
Singapore. La selezione va fatta fin dall’ingresso in formazione.
Nell’attuale situazione di emergenza ( come la definisce il
documento governativo) non si può comunque procedere a massicce
assunzioni senza valutazione, nemmeno se provenienti dalle GAE. Le
leggi si cambiano e si deve dare la possibilità alle scuole
di intervenire prima dell’assunzione, non solo con l’anno di prova
che non ha mai risolto nulla.
No alla progressione retributiva contingentata per merito.
L’ADI esprime il più
fermo disaccordo con la proposta di progressione retributiva
ipotizzata nel documento. Come noto, è prevista la sostituzione
degli scatti automatici di anzianità con un meccanismo che prevede
che in ciascuna scuola un 66% di insegnanti abbia, ogni tre anni, un
aumento retributivo, mentre un altro 33% rimanga al palo. Gli scatti
si chiameranno di “competenza” e saranno valutati su 3 parametri:
merito didattico, formativo e professionale. Detta
brutalmente siamo di fronte a una divisione in “buoni” e “cattivi”,
con l’idea che per i primi il premio costituisca una gratificazione
e una motivazione all’impegno e che per i secondi la punizione
diventi la molla per migliorarsi. Ma questi sistemi non hanno mai
funzionato e non sono in vigore in nessuno dei Paesi dove
l’istruzione funziona bene. E’ da tempo superata l’idea
dell’insegnamento come attività individuale, la convinzione fallace
che il solo potere dei singoli sia in grado di cambiare il sistema.
L’insegnamento può migliorare solo come lavoro di squadra. I singoli
non cambieranno il sistema se non collaboreranno e non svilupperanno
un’impresa collettiva. E questo non potrà avvenire se entro la
stessa scuola gli insegnanti saranno in competizione tra loro per
guadagnarsi un aumento: mors tua vita mea.
No al permanere di una progressione retributiva su 35 anni
Si continua inoltre a
prevedere lo sviluppo degli scatti stipendiali su 35 anni, uno fra i
più lunghi al mondo. Va accorciato. Si può ipotizzare un
abbassamento graduale per tutti gli attuali insegnanti di ruolo fino
a un massimo di 25 anni. Ai nuovi invece bisogna avere il coraggio
di offrire condizioni di lavoro diverse con vantaggi e opportunità
meno impiegatizie e più legate allo sviluppo professionale, con una
progressione retributiva molto più breve, 10 o 15 anni al massimo, e
una retribuzione di ingresso nettamente superiore all’attuale (con
l’eliminazione però della ricostruzione di carriera). E’ giusto ed
opportuno che la progressione sia per tutti collegata ad una
valutazione dell’attività svolta, ma, come si è detto, non può
essere aprioristicamente limitata al 66%, una deleteria corsa
competitiva che, stabilita a livello di singola scuola, creerebbe
anche sperequazioni fra insegnanti di diverse scuole, che ricordano
gli aspetti più controversi del “concorsone” del 2000.
L’assenza
di una strutturata articolazione di carriera.
Ciò che manca nel
documento è la previsione di uno strutturato ed articolato sviluppo
professionale, legato a nuove funzioni. La differenziazione
della carriera docente in Italia è una storia più che trentennale di
fallimenti e rinvii, dovuta certamente a veti sindacali e a carenza
di risorse, ma soprattutto a mancanza di volontà politica. Se ora il
governo, come afferma, vuole riappropriarsi della materia, occorre
che agisca con più coraggio nell’allocazione delle risorse,
riservandone all’articolazione di carriera. L’articolazione
professionale non può limitarsi da un lato al solo docente
mentor, e dall’altro a incarichi temporanei e transitori. Si
dovrebbero, al contrario, ipotizzare fasi successive dello sviluppo
di carriera, con differenziati livelli retributivi, che, per esempio
nell’ambito gestionale, potrebbero condurre fino ai vertici
dell’Amministrazione.
Nessuna decentralizzazione
e poche novità in termini di autentica autonomia.
I risultati di una gestione statalista e centralistica degli insegnanti sono sotto gli occhi di tutti.
Pensare di risolvere i problemi mantenendo lo stesso governo del sistema è non solo illusorio, ma per alcuni aspetti persino colpevole.