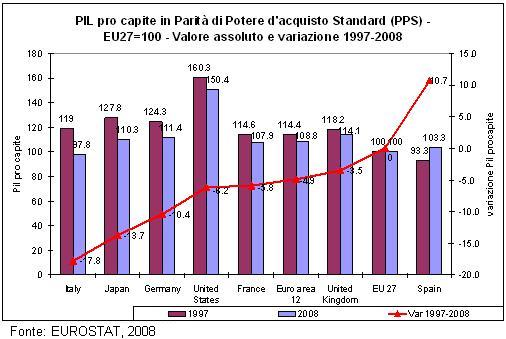L’istruzione italiana invischiata
nella trappola della conoscenza
Laura Chies* economiaepolitica, 27.1.2009
In questi ultimi mesi il dibattito sull’istruzione in Italia si
articola su due grandi temi: la qualità dei risultati (scarsa) e la
dimensione della spesa (eccessiva). Tale dibattito è stato stimolato
dalla pubblicazione di rapporti che illustrano il mondo
dell’istruzione con l’ausilio di numerosi indicatori e confronti
internazionali. La pubblicazione di libri scandalistici, pamphlet
informativi, articoli scientifici ha coinvolto molti economisti e
sociologi, i quali hanno spiegato compitamente dimensione e
caratteristiche del problema. L’intervento più sconcertante è stato
però quello del Governo italiano che ha deciso a priori tagli alla
spesa pubblica e al personale, giustificandoli poi, a qualche mese
di distanza, con motivi riconducibili alla scarsa produttività
didattica e scientifica delle nostre scuole e università. Il dato
negativo sulla qualità dell’istruzione italiana è inserito in un
quadro mondiale che vede le capacità di apprendimento dei giovani
arretrare ovunque tra i paesi avanzati dell’OCSE, ma che colpisce in
modo particolare l’Italia, che parte da posizioni di retroguardia.
Il punto dolente è proprio questo. Perché l’Italia si trova quasi
sempre in coda alle classifiche dei paesi avanzati, quando
l’argomento è lo stato dell’istruzione e soprattutto della
conoscenza? La risposta che si può suggerire è che il coordinamento
istituzionale è assolutamente deficitario. Ognuno degli attori in
gioco (il sistema politico, quello dell’istruzione, quello delle
imprese e il sistema sociale) sembra agire sulla base di finalità
indipendenti, se non addirittura contrapposte. Guardando
all’istruzione dal punto di vista di un economista, la scelta
dell’investimento in istruzione ha un unico obiettivo, quello di
migliorare le prospettive di reddito e di favorire l’aumento del
livello di sviluppo umano ed economico. Leggendo invece le analisi
condotte dal Governo e quelle che derivano dalle indagini sulle
preferenze delle imprese nelle assunzioni, il livello
dell’istruzione degli individui non risulta essere un investimento
altamente produttivo, ma solo un aggravio di costi. Il coordinamento
tra mondo dell’istruzione e quello della produzione pubblica o
privata che sia, appare molto labile. La scarsa valorizzazione del
capitale umano nazionale è evidente nel settore privato, quando si
analizza l’indagine Excelsior di Unioncamere sulle esigenze
occupazionali delle imprese. Gli imprenditori, infatti, non
ritengono l’istruzione una caratteristica importante sia ai fini
della selezione del personale, che per gli scopi della produzione.
Il 60% delle imprese considera il titolo di studio poco o per nulla
importante al fine della scelta del candidato idoneo all’assunzione,
mentre nelle previsioni delle piccole imprese (il 95% circa del
totale delle imprese italiane) l’assunzione di un laureato è un
evento che tocca solo il 5% del totale del turnover annuo. Se il
settore privato non premia l’istruzione, quello pubblico e quello
delle “libere professioni” usa la laurea come una sorta di barriera
all’entrata, dato il valore legale della stessa, più che come utile
strumento di segnalazione di capacità individuali. Le famiglie,
infine, costituiscono il luogo più alto di coordinamento tra gli
incentivi misurati in termini di salari relativi dell’istruzione,
che provengono dal sistema della produzione, e incentivi privati
all’incremento della capacità di apprendimento come strumento di
emancipazione sociale. Entrambi i segnali risultano distorti in
Italia e il risultato è un livello di spesa delle famiglie modesto,
anche se sconta il fatto che la spesa per l’istruzione primaria e
secondaria è per lo più spesa dello Stato e non delle famiglie, che
in totale ammonta comunque a poco più dello 0.5% del PIL
(vedi Tavola sottostante).
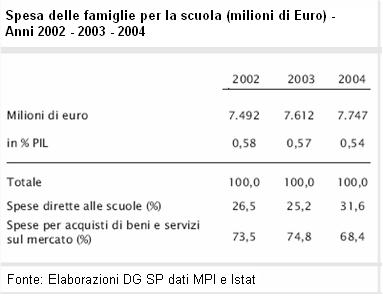
Il risultato è più soddisfacente se visto in termini quantitativi,
infatti, il livello dell’istruzione aumenta tra gli italiani e i
laureati costituiscono poco meno di un terzo degli occupati, ma è la
popolazione in età lavorativa compresa tra i 25 e 64 anni ad essere
ancora poco scolarizzata (solo il 13% è in possesso di una laurea,
contro una media OCSE del 27% e UE del 24%) che male si attaglia ad
un sistema di produzione di frontiera tecnologica proprio degli
altri paesi avanzati [1],
in cui l’istruzione specialistica è il fattore chiave. Un Paese come
il nostro nel quale i costi del coordinamento istituzionale sono
elevati e in cui i risultati della formazione sono modesti, non può
che presentare un sistema di istruzione prevalente di tipo generico
e non specialistico, proprio dei paesi avanzati. L’Italia non è in
grado quindi di sfruttare quei vantaggi di produttività attribuibili
ai lavoratori con profili di specializzazione elevati che compensano
la scarsa produttività dei lavoratori manuali. Il problema reale è
che questi lavoratori altamente specializzati sono troppo pochi e
gli incentivi individuali troppo ridotti per promuovere un vero
cambiamento del sistema. Il fatto più grave è che gli attori
principali politici, economici e sociali non riescano ad avere una
visione unica del problema rappresentato dal debole legame tra
produttività e capitale umano e che offrano come soluzione la
riduzione della spesa, sperando che in una situazione di scarsità di
risorse passa emergere spontaneamente un equilibrio economico
migliore. Il risultato del mancato coordinamento è preoccupante. Se
nel 1997 potevamo affermare con soddisfazione di aver raggiunto e
superato il livello di reddito pro capite medio dell’Europa a 27
Paesi di ben 19 punti, oggi le previsioni Eurostat ci pongono in
netto svantaggio rispetto agli altri partner (vedi grafico) sia
rispetto alla variazione del PIL pro capite (-17,8% tra il 1997 e il
2008), sia rispetto al valore di parità. Fatto 100 il valore di
parità UE a 27 Paesi l’Italia segna oggi un misero 97,8.
* L’autrice è
professore associato di politica economica nell’Università di
Trieste.
[1] Si veda Oecd (2008), Education at
Glance